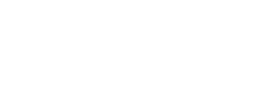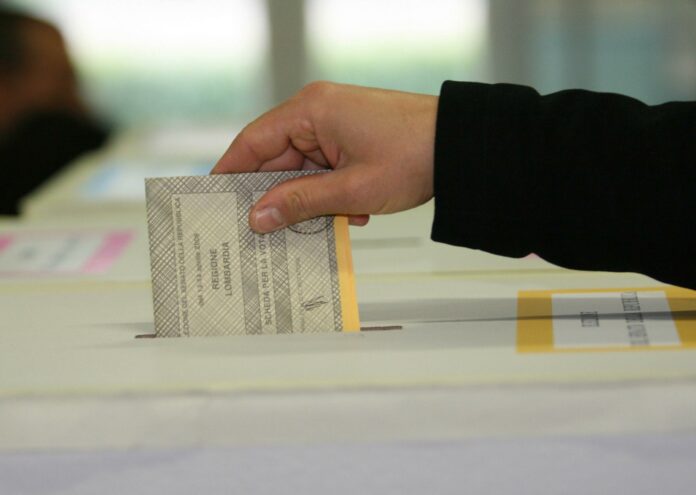Una volta che le urne saranno chiuse, chi vincerà le elezioni si troverà di fonte alle grandi questioni: globalizzazione, multietnicità, innovazione tecnologica, liberalizzazioni, risanamento del bilancio, ecc. Come affrontarle andando, magari, al di là dei tanti luoghi comuni che si ascoltano in queste settimane?
Il prossimo 13 aprile andremo alle urne. Saranno elezioni epocali, e non per l’avvento di qualche figura o partito politico in grado di stravolgere gli eventi, ma perché gli eventi che stanno maturando sono sconvolgenti di per sé. I temi che si vanno ponendo e imponendo, anche se sono ignorati, progressivamente emergono. La sfida economica parte dalla globalizzazione, dai processi migratori, dalle questioni della multietnicità, dalle conquiste tecnologiche che sfidano l’etica corrente. È sempre più necessario pensare in chiave di futuro a lungo termine, ipotizzare scenari. A fronte di tutto ciò le riproposizioni che si sentono da un lato e dall’altro sembrano veramente inadeguate.
Privatizzare e liberalizzare: slogan o realtà?
Per il rilancio dello sviluppo economico, si continua a ripetere che la ricetta magica sta nel binomio privatizzare e liberalizzare. E sempre più spesso, specialmente fra i giornalisti, i due termini si confondono, almeno in chiave di conseguenza, attribuendo alle privatizzazioni gli effetti delle liberalizzazioni. In ogni caso, il requisito genericamente più atteso da privatizzazioni e/o liberalizzazioni è quello di determinare benefici per i consumatori finali, sotto forma di riduzione dei costi e di miglioramento dei servizi. Basandoci sulle esperienze fin qui condotte, non ci sembra però che si siano registrati gli effetti auspicati.
Le privatizzazioni, tipo quelle di Autostrade, non hanno calmierato i pedaggi né migliorato significativamente la viabilità. La cessione di quote crescenti di Eni al libero mercato ha solo consentito al Tesoro di introitare meno dividendi di quanto non abbia incassato cedendo le quote. La vendita del Nuovo Pignone ha portato benefici solo alla General Electric. Nel sistema bancario le privatizzazioni hanno fatto sì che si passasse da un regime oligopolistico con presenza pubblica a uno oligopolistico solo privato. Ciò che finora non è stato privatizzato, non lo è stato perché non era ancora sufficientemente profittevole (leggi FS e Poste), ma non appena le pietanze saranno calde qualche acquirente emergerà.
Diverso il tema delle privatizzazioni delle aziende locali, ma anche qui occorre prestare molta attenzione: privatizzare la distribuzione di una risorsa indisponibile come l’acqua, ad esempio, fa paura. Certamente le amministrazioni locali devono smettere di creare delle piccole Iri in ogni comune e regione, e soprattutto le aziende vanno sottratte al controllo politico della gestione, anche se spesso la politica controlla pure i privati. Per quanto riguarda infine le liberalizzazioni, nel classico corrente queste sono sinonimo di efficacia, concorrenza, competitività, abbassamento dei costi. Ma se la teoria economica dice questo, la pratica non sempre lo conferma. Anche qui bisogna distinguere con molta attenzione, perché molto spesso la liberalizzazione del passaggio finale è vincolata, e dunque resa inefficace, da blocchi monopolistici a monte.
I parametri di Maastricht non sono un dogma
L’Italia è attraversata da una crisi economica e sociale che viene da lontano, ma che proietta la propria ombra anche nel futuro. Le radici delle nostre difficoltà sono profonde e strutturali: basti pensare alla mancanza di materie prime ed al crescente onere finanziario necessario per approvvigionarsene. Il processo di globalizzazione internazionale accentua le nostre deficienze strutturali, ma la vera zavorra che appesantisce la politica economica è rappresentata dal debito pubblico e, soprattutto, dai vincoli posti dal Patto europeo di stabilità: 3% del rapporto deficit/Pil come “stella polare” immodificabile. Il Patto di stabilità non si discute, ma il 3% non è né un dogma né un valore derivante da una legge fisica. Quando i parametri di Maastricht furono fissati, il quadro di riferimento generale dal quale derivarono era totalmente diverso: le quotazioni del petrolio oscillavano introno ai 30 dollari, mentre un dollaro veniva cambiato fra le 1.500 e le 1.600 lire. Non solo, ma lo scenario geopolitico è completamente mutato e inasprito, e richiede quindi un impegno finanziario crescente cui sono sottoposti i Paesi Nato. L’Italia è dopo Stati Uniti e Gran Bretagna il Paese più presente nelle missioni di stabilizzazione: oltre 10 mila uomini sono attivi nei vari scenari internazionali, con la prospettiva di un crescente impegno finanziario (basti pensare all’Afghanistan).
Il Patto di stabilità non si discute, ma il 3% non è né un dogma né un valore derivante da una legge fisica. Quando i parametri di Maastricht furono fissati, il quadro di riferimento generale dal quale derivarono era totalmente diverso: le quotazioni del petrolio oscillavano introno ai 30 dollari, mentre un dollaro veniva cambiato fra le 1.500 e le 1.600 lire. Non solo, ma lo scenario geopolitico è completamente mutato e inasprito, e richiede quindi un impegno finanziario crescente cui sono sottoposti i Paesi Nato. L’Italia è dopo Stati Uniti e Gran Bretagna il Paese più presente nelle missioni di stabilizzazione: oltre 10 mila uomini sono attivi nei vari scenari internazionali, con la prospettiva di un crescente impegno finanziario (basti pensare all’Afghanistan).
Rispetto all’epoca della fissazione dei parametri, anche l’impegno per la gestione dell’immigrazione clandestina è enormemente aumentato: siamo una delle “porte” verso l’Europa dal Nordafrica. Insomma l’Italia è sottoposta a uno sforzo maggiore nell’interesse non solo proprio ma della compagine internazionale. D’altra parte, il Patto di stabilità non può essere rigido, ma dev’essere in grado di assecondare l’evolversi dei fenomeni economici e politici e del quadro internazionale, per non favorire qualcuno a scapito di altri.
Ridiscutere i parametri di Maastricht è probabilmente un’illusione teorica, o comunque di lungo tempo. Però si potrebbe, concretamente, chiedere che le spese sostenute per il mantenimento dei contingenti militari all’estero non vengano conteggiate nella definizione del rapporto deficit/Pil. In fin dei conti, il senso politico del Patto di stabilità è quello di consentire un progressivo rientro del debito per i Paesi più esposti rispetto alla medie, secondo un certo ritmo e tempo.
L’Italia non sarà mai in condizione di rientrare dal debito (ossia rispettare i parametri), sostenere lo sviluppo e la qualità della vita e, nel contempo, mantenere o aumentare il proprio impegno militare nel mondo. Partecipare si può, pagare il costo per chi si impegna meno no. L’equazione del sistema economico italiano in questi ultimi anni ha sempre dato risultati negativi.
Articolo pubblicato su Professione Dirigente, periodico Federmanager Roma, n. 20/Marzo 2008