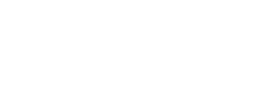A partire da ottobre le tariffe di luce e gas hanno subito un ulteriore incremento secondo i calcoli effettuati dall’Autorità per l’Energia.
Contemporaneamente, a seguito dello scatenarsi del ciclone finanziario, le quotazioni di petrolio e gas sono, almeno momentaneamente, precipitate. Non solo, ma il prezzo dei carburanti, che gli utenti registrano quotidianamente, mostra un’estrema rapidità nell’adeguarsi al rialzo mentre manifesta una lenta discesa quando le quotazioni si contraggono.
I consumatori finali sono perciò quantomeno disorientati di fronte a questa situazione schizofrenica, e non possono non sentirsi vittime di tradizionali abusi, con relativa perdita di credibilità verso l’Authority stessa. In effetti, il meccanismo che presiede a queste valutazioni è poco comprensibile, visto che gli aggiustamenti tariffari per luce e gas avvengono con una metodologia per cui ogni trimestre sono prese in considerazione le quotazioni dei 6/9 mesi precedenti.
Così, ad esempio, la punta massima delle quotazioni del greggio a 150 dollari al barile verrà registrata nel trimestre che comincia a gennaio 2009, mentre i ribassi ai quali stiamo assistendo avranno effetto solo nella primavera dell’anno prossimo. Per i carburanti, invece, l’Autorità per l’Energia non fornisce indicazioni. D’altra parte, il ricalcolo al ribasso non può essere sempre proporzionale alle quotazioni delle materie prime di riferimento. Vediamo perché.
Che cosa incide sul prezzo dei carburanti
L’Autorità per l’Energia ha ereditato alcune funzioni che erano del CIP (Comitato Interministeriale Prezzi). L’unica differenza è rappresentata dal fatto che il CIP aveva un potere autorizzativo, mentre quello dell’Authority è un potere consultivo, autorevole e condizionante ma nulla di più. Inoltre, fra i pareri esposti in materia di quotazioni dei carburanti, non sembra ci siano molti pronunciamenti e approfondimenti. È dato per acquisito, ad esempio, che esista un differenziale tra le quotazioni di benzina e gasolio in Italia rispetto alle medie europee. Un differenziale fra 7 e 12 centesimi di euro per litro a danno del nostro Paese.
È dato per acquisito, ad esempio, che esista un differenziale tra le quotazioni di benzina e gasolio in Italia rispetto alle medie europee. Un differenziale fra 7 e 12 centesimi di euro per litro a danno del nostro Paese.
La diagnosi su questo delta ha quasi sempre posto l’attenzione sulla “distribuzione finale”. Tesi, questa, sostenuta dall’Unione Petrolifera: troppi punti vendita, erogato medio basso, compenso ai gestori elevato, poca differenziazione merceologica. Tale spiegazione è in parte condivisibile ma non fa comprendere tutto il fenomeno e, soprattutto, sposta l’attenzione da un altro fattore strutturale ancor più significativo: l’arretratezza del sistema di raffinazione in Italia.
Nel nostro Paese la capacità media delle raffinerie è di circa il 20% inferiore a quella europea, con una conseguenza pesante sui costi di lavorazione. E non solo la capacità media è inferiore, ma anche il posizionamento logistico di alcuni impianti è assolutamente penalizzante: si pensi, ad esempio, alla raffineria Eni di Marghera a ridosso di Venezia, o a quella Api di Falconara che sfiora la strada statale Adriatica e la linea ferroviaria o, ancora, a quella ubicata all’interno di Cremona, solo per citare i casi più emblematici. E le raffinerie più efficienti sono posizionate nelle isole maggiori, dunque i baricentri di produzione sono distanti da quelli di consumo. Di tutto questo, però, l’Autorità per l’Energia sembra non accorgersi nel predisporre un listino teorico di riferimento su una possibile giusta quotazione del prezzo finale dei carburanti. Così come non viene mai presa in esame la diversa condizione di chi opera nel mercato disponendo di greggio di proprietà rispetto agli operatori che acquistano sul mercato.
Ci sono diverse condizioni di redditività che dovrebbero significativamente registrarsi nelle quotazioni finali. Ma forse un’analisi più ampia e approfondita potrebbe turbare gli equilibri di un mercato che pensava (illusoriamente?) di trovare nella concorrenza fra gli operatori il modo per calmierare le quotazioni finali.
Articolo pubblicato su Professione Dirigente, periodico Federmanager Roma, n. 23/Novembre 2008