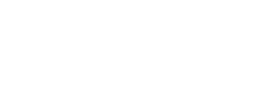IL MACIGNO (ed. Feltrinelli), scritto con estrema chiarezza da Carlo Cottarelli, parla dei rischi ai quali l’Italia rimane esposta e dei costi che comunque essa deve affrontare per effetto dell’elevato debito pubblico. Ecco in sintesi le sue argomentazioni
Quant’è grande il debito pubblico
A fine 2014 il debito pubblico (DP) italiano ammontava a 2.136 miliardi di euro, pari a 35 mila euro pro capite, e il rapporto DP/PIL era pari al 132% (si stima che a fine 2015 sia attestato a 133). È tanto? È poco? È sostenibile? Il valore raggiunto è anomalo rispetto alla serie storica (85% la media dall’unità d’Italia ad oggi). L’impennata si è avuta a partire dal 2008 in corrispondenza con la crisi economica e il crollo del PIL. Nel confronto internazionale l’Italia è mal posizionata risultando il terzo Paese al mondo dopo Giappone e Grecia. Ma il semplice posizionamento statistico ha poco significato. Ad esempio, è fondamentale rilevare che il nostro DP è detenuto per oltre il 70% da cittadini italiani.
Comunque un DP troppo elevato espone il Paese al rischio di improvvise crisi finanziarie come quella del 2011: genera sfiducia nei mercati e quindi la necessità di aumentare i tassi di interesse; innesca quindi una spirale negativa che fa esplodere la sostenibilità finanziaria. Il Fondo Monetario Internazionale ritiene tollerabile un DP pari al 70% del PIL per i Paesi in via di sviluppo e dell’85% per quelli industrializzati. Un po’ di DP (40/50% del PIL) aiuta lo sviluppo, il suo eccesso lo comprime. Per ridurlo Cottarelli ipotizza alcune soluzioni, anche se in certi casi le conseguenze negative appaiono maggiori di quelle positive.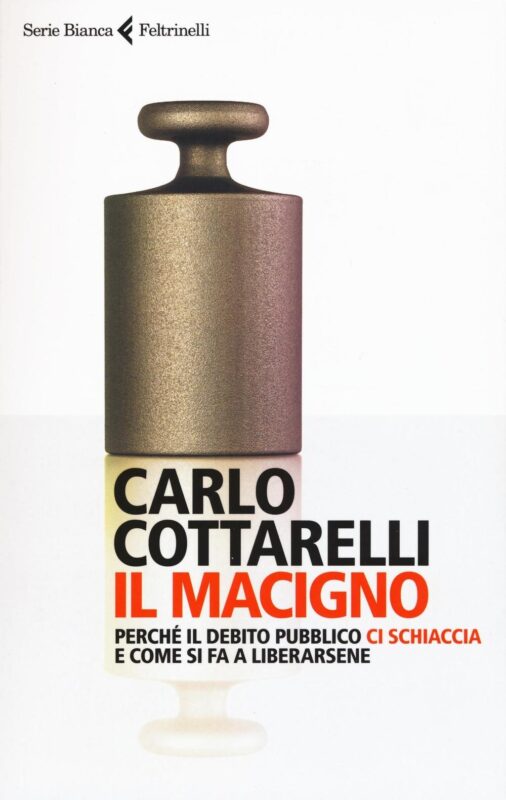 Alcune idee per ridurlo
Alcune idee per ridurlo
- Uscire dall’euro. L’ipotesi ha avuto la massima forza nei momenti più acuti della crisi finanziaria, quanto lo spread era arrivato a oltre 500 punti, e alcune forze politiche lo sostengono adducendo le seguenti motivazioni: a) La mancanza di una sovranità monetaria non consente di dare la certezza del rimborso ai mercati (magari stampando moneta); b) L’appartenenza all’area dell’euro diminuisce la competitività e la crescita del PIL; c) Stare nell’area euro impone il rispetto di vincoli e parametri che ci penalizzano.
D’altra parte, immettere moneta sul mercato in misura rilevante senza correggere gli squilibri fra entrate ed uscite fa sì che la moneta emessa perda valore e quindi si attivi un forte processo inflattivo che erode il potere d’acquisto di quel 70% di possessori nazionali di titoli di Stato. Lo stesso sistema bancario detiene grande quantità di titolo pubblici e si troverebbe in gravi difficoltà. Si stima che l’inflazione attesa per consentire una significativa riduzione del DP dovrebbe essere almeno del 25%. Ma il sistema Italia ha perso competitività in termini di produttività ed efficienza: ricorrere alla svalutazione significa rinviare gli obiettivi dell’efficienza in un quadro internazionale sempre più competitivo.
- Ripudiare il debito. La storia ha visto Paesi che non hanno rimborsato il debito (fra i più recenti si ricordano Argentina e Grecia). Ma ripudiare il debito sarebbe estremamente oneroso per coloro (70% italiani) che detengono titoli di Stato. E il Paese perderebbe credibilità ed affidabilità e sarebbe sempre più difficile collocarne i titoli nei mercati internazionali.
- Mettere il DP in comune con i partner europei. Sarebbe bello, ma richiede condizioni di solidarietà e di reciproca convenienza di cui non esistono i presupposti.
- Vendere e valorizzare le proprietà della pubblica amministrazione. È un’operazione da perseguire, ma da sola non basta al contenimento significativo del DP, senza contare la necessità di superare l’attuale sistema burocratico, con difficile valutazione dei tempi entro cui registrare risultati concreti.
Conclusioni
Per l’Autore l’unica linea possibile consiste nel combinare una moderata austerità fiscale con riforme che favoriscano la crescita del PIL. L’obiettivo deve essere il pareggio di bilancio da raggiungere in tre anni, secondo quanto previsto dalla Nota di aggiustamento al Documento di economia e finanza e dalla Legge di stabilità 2016, senza elevare gli attuali livelli di tassazione e mantenendo la spesa primaria costante in termini reali tra il 2016 e il 2019. Certo, per molti anni ancora dovremo convivere con un DP molto elevato (scenderebbe al 90% del PIL nel 2029), ci vorranno tempo e pazienza, ma bisogna crederci se si vuole evitare che il Paese resti per sempre schiavo del debito e dei mercati finanziari.
Considerazioni a latere
L’orientamento di Cottarelli appartiene alla scuola dei rigoristi, ed è difficile contraddirlo in un Paese in cui deresponsabilizzazione e leggerezza sono la cultura dominante. Ma l’Autore non affronta mai l’altro aspetto, quello dei parametri/vincolo fissati come condizione di appartenenza all’euro. A cominciare dal tetto massimo del 3% del rapporto tra deficit e PIL. Questo valore, fissato all’inizio dell’euro, è l’architrave intorno al quale si apre il continuo confronto/ scontro tra i vari Paesi per ottenere deroghe. Con soluzioni di volta in volta compromissorie e non sempre equilibrate. In verità, a mio modesto avviso, l’errore commesso all’epoca fu quello di fissare un parametro rigido e non adeguabile nel tempo. Al momento dell’istituzione dell’euro (2001) il quadro di riferimento internazionale registrava alcune condizioni: un certo valore del dollaro, una Cina non ancora ammessa al WTO, un quadro radicalmente diverso dei processi migratori che gravano oggi pesantemente e non in modo omogeneo sui bilanci dei diversi Stati, e così via. Appare quindi necessario ripensare i parametri per l’appartenenza all’area euro correlandoli con chiarezza alle condizioni dello scenario economico globale ed ai suoi mutamenti. L’alternativa è il permanere del concetto burocratico del rispetto di un criterio che non ha oggi nessuna giustificazione tecnica plausibile.
Articolo pubblicato su Professione Dirigente, periodico Federmanager Roma, n. 51/Luglio 2016